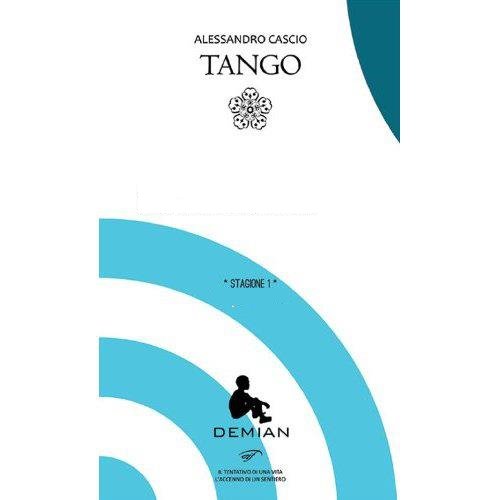Tango (Romanzo breve, versione integrale)
Tango
di Alessandro Cascio
Ce ne stavamo accalcati, stretti l’uno all’altro, per riscaldarci.
Non era l’Inverno a farci tremare ma i freddi “Kühe heraus!” e le risa delle guardie che risuonavano in un atipico silenzio. I giostrai erano in fila, li vedevo camminare verso i camion, piegati, stanchi, senza più nulla del loro fuoco, quello pieno di festosità che avevo visto nei giorni in cui ancora tutto doveva accadere. Non c’era più nulla, né cenere né fumo, e tutto perché qualcuno aveva scambiato il loro calore per le vampate ardenti dell’Inferno. Anche i docili sentimenti di un amore ingenuo, possono tramutarsi in un mare inquieto in cui anche i pesci annegano, se incontrano le forti correnti della gelosia.
Da quel giorno mi sveglio senz’aria, con un sussulto, ogni mattino mi si schianta in viso come fosse vetro e fa male. Mi chiedo semmai un giorno la luce tornerà a darmi pace e la smetterà con tutta quest’inutile violenza.
“Rispondi” grido: “Adeline!”
Ci sono miliardi di piccole campane suonate da altrettanti agitati folletti dentro al telefono che Adeline ha deciso di regalarmi per averle ridato le gioie della sua gioventù. O forse quel telefono trema soltanto, emana un suono sordo e tutto questo fracasso è nella mia testa.
“Dovresti regalarmi anche degli amici e una famiglia, se vuoi che quell’affare suoni” le ho detto, ma mi sono subito passato una mano in faccia sperando di farla venir via come fosse disegnata coi pastelli.
Sapevo che avrebbe risposto: “Sono io la tua famiglia, sono io la tua amica”.
Già Adeline, ma se tu sei la mia famiglia, se tu sei la mia amica, chi mai sta chiamando da mezz’ora almeno?
Mi siedo, prendo un bicchiere di qualcosa:
“Il telefono, rispondi a quel cazzo di telefono”, che squilla imperterrito come un bebè che se l’è fatta sotto, dev’essere importante, chissà che faccia farà quando scoprirà di aver sbagliato numero.
Poi smette e il silenzio sembra quasi più fastidioso.
Adeline si trascina per la casa silenziosa cercando di non frantumare l’aria che impatta. Non c’è rumore più assordante dei mille strepiti di chi è fatta di massa che vibra ad alte intensità e ciononostante vuol essere leggera. Io poi, che sono come una piuma puntata con uno spillo a una foglia nell’angolo più ventoso del Mediterraneo, percepisco la sua pianta del piede che sprofonda nel tappeto di stoffa, il gomito che strofina sulla vestaglia di seta marocchina e lo sfregare dei suoi denti quando si accorge che ho avvertito la sua presenza alle mie spalle.
Mi abbraccia. E’ nuda. Cristo Dio, potrebbe essere mia madre!
Quello che stiamo facendo è al contempo qualcosa di orribile e tenero, lei ha bisogno d’amore e io di un posto dove nascondermi e una buona cena quando mi torno a Parigi.
“Non mi dai neanche il buongiorno?” dice: “Sei sempre così silenzioso”.
Ultimamente parlo poco, è vero. Non è che non abbia nulla da dire, è solo che non voglio essere d’ispirazione a nessuno.
E poi di nuovo quel maledetto telefono.
“Adeline”.
Non si decide a prendere ordini, così allungo il braccio e: “Ha sbagliato numero” dico.
Risponde una voce piccola piccola, dev’essere uno dei folletti del telefono che vuole rimproverarmi di avergli fatto fare gli straordinari.
“No, non ho sbagliato. Tu sei Olivier, giusto? Mi chiamo Jacky, tu devi un favore al mio uomo.”
Ha detto tutto lei, praticamente si è telefonata da sola.
“C’è un solo uomo a questa terra a cui devo un favore” rispondo.
“Maurice” dice la donna, “Maurice Debar”.
Già, lui.
Julka, la cartomante cieca, diceva che il fuoco dei giostrai di annunciava giochi e danze, che più sarebbe stato alto quel fuoco più quelli avrebbero danzato e i loro canti avrebbero portato onore alla terra. Diceva che i giostrai non credono al cielo e per questo la gente li aveva condannati: ma se il cielo ama la terra come fa un gitano, il cielo stesso è gitano.
Nessun uomo dovrebbe mai augurare l’Inferno ai gitani, perché getterebbe su di sé sventure tali alle quali neanche la magia può opporsi. Il piccolo borgo di Pollestres invece, li aveva condannati e aveva sfidato ogni divino e per questo credevo che, di lì a poco, qualcosa di brutto sarebbe accaduto.
“Figli del Diavolo” li chiamava il parroco a messa e noi, vestiti da chierichetti, sgomitavamo.
“Concubine e streghe” sussurravano le donne col capo velato di seta nera, “concubine e streghe”
“Oh, guardami” cercavo di attirare l’attenzione di Marcel che, immobile, impastava una preghiera che non aveva mai imparato. Le preghiere erano troppe e tutte dicevano su per giù la stessa cosa, quindi tanto valeva fare come ci aveva insegnato Antoine l’organista. Ci aveva detto: “Imparate le parole importanti che quasi sempre sono amen, cielo, santo, tutte si somigliano, poi fate come se masticaste della gomma e mugugnate”.
Mugugnavo a modo mio per far ridere Marcel. In ginocchio a mani giunte e a testa bassa, muovevo il sedere come Citronceka, la farfalla dei giostrai.
“Padre nostro um cha cha. Um cha cha, nei cieli, cha. Um cha cha glorifichiamo, um cha cha peccati cha!”
Marcel rideva. Timido com’era, se avesse beccato una sgridata durante la messa sarebbe come minimo svenuto dalla vergogna, ma io continuavo perché vederlo svenire era sempre meglio che vederlo pregare: “Um cha cha, ave Maria, um cha cha, che sei nei cieli!”
Il fuoco dei giostrai era alto: la sera ci sarebbero stati i mangiatori di vetro e i serpenti e Julka avrebbe letto le carte per pochi spiccioli. Poi sarebbe arrivata la farfalla danzante. Lei avrebbe ballato, le sue gambe si sarebbero scoperte a ogni giravolta e in uno di quegli attimi mi sarei gettato in terra per vederle le mutandine sotto la gonna colorata e piena di campanellini. Le avremmo visto i piedi nudi, il petto scoperto e le natiche tonde, sporgenti e ondeggianti, per tutta la sera.
Le donne di Pollestres odiavano Citronceka e tutte le gitane, le consideravano figlie del diavolo, per questo smisi di pregare ancor prima di imparare a farlo, perché dagli occhi delle comari della chiesa madre, capii che il paradiso non aveva nulla da offrirmi che davvero desiderassi.
“Um cha cha. Andiamo dopo?”, chiesi a Marcel, ma quello non rispose e inclinò la testa come a far finta che non esistessi.
“Um cha cha, ti sfido a mangiare, amen, il vetro come quel vecchio al campo, un solo pezzo, amen”, ma Marcel guardava in terra, come se volesse scomparire sotto quelle lastre di marmo che costavano più di quanto pesavano e che con le calze di lana ai piedi diventavano una pista di pattinaggio su cui slittare durante l’ora di refettorio. Sentii il mio orecchio spostarsi oltre il consentito trascinando con sé la mia testa e il mio corpo fino al leggio al centro della navata.
“Vuoi recitarlo tu il Salve Regina?” chiese il prete.
Mi ritrovai con poche parole nella mente e tanti mugugni nei ricordi.
“Salve Regina” dissi e mi fermai subito dopo. Dalla prima alla decima fila, tutta la scala gerarchica della santa messa mi aveva puntato gli occhi addosso borbottando a Dio di avere pietà della mia anima.
In prima fila c’erano i matusa con le chiavi del Paradiso a tracolla e il salvadanaio pieno per lasciare una cospicua mancia al chierichetto, speranzosi di un servizio efficiente dopo la dipartita. In seconda fila i “riempiposto”, per lo più pensionati in aspettativa che dopo la morte di un matusa, avrebbero riempito il vuoto lasciato nelle panche davanti. In terza fila c’erano i “condannati”, gente che qualche anno prima la vedevi nelle file dietro a ridere, spettegolare, dormire o puntare con gli occhi zitelle e scapoli in cerca di un’avventura. I condannati erano ultracinquantenni che avevano da poco acquisito la consapevolezza di dover morire, cosa che in quarta fila sembrava lontana nonostante le panche distassero l’una dall’altra lo spazio di un uomo in ginocchio più le suole delle sue scarpe.
Quello che davvero m’importava era che Doriane, seduta in sesta fila, rideva di me che rosso come mio padre tornato dall’osteria mi scusavo col prete che cercava di smuovermi le preghiere spingendomi le parole giù per il naso con una botta in testa. Di fronte, intravedevo la sagoma di Marcel, rannicchiato su se stesso e imbarazzato, proprio lui che mi aveva sempre visto come un fratello maggiore nonostante fossi più piccolo di otto mesi. Così mi trovai a un bivio, d’innanzi a quella scelta che tutti i ragazzi alla mia età prima o poi si trovavano a dover fronteggiare: diventare un uomo o rimanere una mezza sega.
“Salve Regina” gridai.
“L’hai salutata già” ripeté il prete.
“Misericordia, madre um cha cha. Cristo, cielo, lacrime, cha!”
Sfuggii alla mano del prete e cominciai a danzare e muovere il culo come Citronceka, alzando le ginocchia alla fronte con dei saltelli e scoprendo le gambe sottili e i pantaloncini da ginnastica azzurri sotto la tunica.
“Noi ti preghiamo, discepoli, um cha. Speranza, anima, amen, cha cha!”
Marcel mi seguì e assieme corremmo per le vie del campo. Gli gridavo di scappare e di non guardare indietro.
“Tu sei un pazzo” mi disse, “ci uccideranno, i miei lo faranno, il parroco lo farà, oppure ci metteranno in collegio dalle suore, tutti e due”.
Io galoppavo verso Citronceka e i giostrai, il loro fuoco mi brillava negli occhi, e pensavo al viso stupito di Doriane che l’indomani mi avrebbe guardato come mai aveva fatto da quando si era trasferita a Pollestres dalla città di Perpignan.
“Ne è valsa la pena. Dillo che ne è valsa la pena!”
“Non c’è nulla che io conosca, per cui valga la pena morire”.
Potevo sentire i violini suonare e quegli strani strumenti accompagnarli.
“Corri Marcel, che domani potremmo pure morire, per questo stanotte voglio vederle i seni!”
“Finirai all’Inferno per questo e per tutto il resto. Non si scappa da una chiesa, non si dice seni!”
“L’hai appena detto anche tu, sei scappato anche tu!”
“Oh santo Dio!”
“Ci confesseremo domani e ci faremo perdonare anche la tua bestemmia”.
Il cerchio di gente che attendeva la danza della farfalla era composto di gitani e qualche contadino in incognito, convinto che lì nessuno del paese si sarebbe mai avvicinato. La musica, le voci e le risate avevano un forte sapore di proibito, ma mai quanto lei che ballava di fronte al violinista.
“In terra” dissi, “ti dico di che colore ha le mutandine”.
Marcel mi rispose che al massimo le avrei visto le ginocchia, da quel punto, e così strisciai fino al gruppo di balordi che le stava più vicino e dissi: “Rosse!”
“Non esistono le mutande rosse” rispose Marcel.
“Ma sì, ti dico che sono rosse”
“Le mutande sono bianche, tutte quante”
“E se ti dicessi che sono bianche?”
“E’ facile così: tutte quante lo sono.”
“Allora che te lo dico a fare se non ci credi comunque? Sono rosse, ti dico, sono rosse!”
Quando mi voltai nuovamente, mi trovai solo sul selciato, la gente si era tirata indietro all’avanzare di Citronceka. Ero di nuovo al centro dello spettacolo, come in chiesa, ma questa volta non c’era un burbero parroco a tirarmi le orecchie, ma la farfalla dei giostrai che a gambe larghe cominciò a passarmi sopra ballando, senza calpestarmi, anche se avrebbe potuto farlo se solo avesse voluto. E la gente rideva divertita.
“Che fai di spalle, stupido?” mi gridò Marcel: “Voltati!”
Lo feci, ma sotto le sue gambe era buio, la gonna oscurava tutto, potevo sentire il suo bacino muoversi dal tessuto che mi si sfregava addosso accarezzandomi il corpo. Chiusi gli occhi e cercai di sentire il suo odore. La gente fuori dal mio proibito mondo tra le gambe della farfalla, applaudiva e mi scherniva.
“Coma va piccolo?” diceva: “Una volta fuori da quella gonna sarai un uomo!”
Misi la mano davanti per coprire l’eccitazione che veniva fuori dalle braghe larghe e restai immobile ad assaporare il profumo di lei, che si piegò sulle gambe.
Le vidi le mutande, erano bianche. Aveva ragione Marcel: non esistono le mutande rosse.
Un uomo mi tirò per i piedi e si coricò al posto mio, ma Citronceka indietreggiò. Scappai verso i tre alberi d’ulivo dietro la capanna dei cani. Scappai facendomi spazio tra la folla, facendomi spazio tra le mani che tentavano di fermarmi e schiaffeggiarmi, scappai da Marcel che provò a trattenermi. Mi corse dietro per tutto il tragitto, fin quando, stanco della corsa, mi trovò seduto.
“Cosa fai?” chiese.
Le mie mani, rapide, cercavano di buttare fuori quella strana percezione di mancata quiete che dopo un brivido, mi avrebbe piegato in due lasciando spazio a quel senso di colpa che avrei poi liberato dentro un confessionale al prezzo di qualche preghiera: ma questa volta avrei dovuto imparare ogni parola per essere salvato dall’Inferno.
“Ti tocchi?” disse Marcel e fece il verso del vomito. Mi derise, ma non capiva, non avrebbe potuto mai capire, lui, cosa fosse quell’odore che ti dà la sensazione del sapore al solo sentirlo.
“Le ho visto tutto!” dissi.
Curvato su me stesso riuscii a vedere la folla che si accalcava, che si spostava, che andava prima indietro e poi avanti, le grida, gli urli …
L’uomo che si era coricato al posto mio aveva insistito per guardare sotto la gonna della farfalla dei gitani e più volte l’aveva tirata a sé. Era mio padre, ubriaco e malconcio come mai lo avevo visto. La gente pensava che fossi di buona famiglia, ma solo i gitani conoscevano la verità su di lui e di rimando, la verità su quello che sarai diventato. Mia madre e un gruppo di donne di Pollestres mi avevano seguito, avevano portato con loro gli uomini ben voluti e alcuni dei più beceri del borgo e si erano appostati tutti a qualche metro dalla festa.
Era una brava donna, mia madre, bella come una farfalla danzante, ma una farfalla danzante che non danza va contro natura, presto o tardi muore. Alla vista di mio padre trattenne le lacrime, le altre donne la strinsero e qualche secondo più tardi cominciarono a inveire: “Sgualdrine!”
Ma io, nascosto dietro ai sassi, sapevo che ognuna di loro in quell’istante avrebbe voluto volare come Citronceka, avrebbero voluto avere quella magica capacità di ammaliare gli uomini che avevano perso standosene per tutto quel tempo a grattarsi le ginocchia sulle panche di una chiesa. Forse la bellezza sta nelle ginocchia e se le usuri troppo anche quella poi si usura. Bisogna tenerle nude, le ginocchia, bisogna lasciare che si muovano a tempo e il tempo, che appartenga al diavolo o a Dio, sarà clemente.
Mio padre aveva preso dei calci, per quello si era arrabbiato e si era alzato cercando quale tra quei piedi in cerchio attorno a lui fosse il colpevole. Ne prese alcuni e li calciò a sua volta e da lì a poco tutto sarebbe cambiato. Si beccò una coltellata al cuore e arrivò alle cure pronto per l’estrema unzione. Durante il funerale non eravamo accanto al prete a mugugnare, ma stavamo a testa china, rimproverati da un’omelia che ci rendeva tutti colpevoli dell’accaduto. Nessuno sapeva che mio padre, in realtà, era morto a causa mia, perché vedendomi sotto la sottana di una gitana, aveva voluto provare quello che io avevo provato. Ero un assassino, ero condannato, o forse di più, ero un diavolo in persona, ero uno di quelli che appiccano il fuoco ai dannati. Nulla di ciò mi spaventava, piuttosto mi stava a cuore la fine di Citronceka. Aver condotto fin lì la gente di Pollestres era forse la mia colpa maggiore. Ma non potevo vederla, non potevo staccarmi da mia madre, non potevo uscire da casa, potevo solo origliare alla porta quando qualcuno veniva a bere un caffè al pomeriggio.
Dicevano: “Li vogliono cacciar via quei diavoli!”
Dicevano: “Vogliono dar fuoco all’accampamento!”
Dicevano: “Se l’è cercata. Che Dio perdoni vostro marito!”
Parlavano dei gitani e di qualcuno che sarebbe arrivato a portarli via.
Dicevano: “Qualcuno li ha chiamati stamane!”
Dicevano: “Arriveranno a momenti”.
“I gitani amano la terra quanto la ama il cielo”, diceva Julka la cartomante cieca “e chiunque condanni i gitani condanna il cielo stesso”.
Un giorno avevo seguito Citronceka fino alla tenda. Pensavo che non mi avrebbe visto, che mi avrebbe confuso col crepuscolo e i corvi e questo fu quello che mi lasciò credere fino a quando un castigliano non mi prese per le spalle e mi alzò come fossi fatto d’aria. Scalciai così forte da farmi scrocchiare le ginocchia.
“Ti piacciono così tanto le mie danze?” chiese Citronceka.
Le parole mi rimasero nello stomaco, cercai di mascherare la paura rimanendo immobile come un albero, che quelli si prendono le botte dall’inverno e non si lamentano. Io le avrei prese da un gitano della Junquera e sarei stato zitto come un albero.
Mi disse: “Non aver paura, non farei mai del male al mio miglior ammiratore”.
Il castigliano mi lasciò, posandomi come si posano le cose e anche lui mi sembrò buono di colpo, anche una faccia brutta con la giusta smorfia di piacere può diventare sopportabile.
Prese il violino e “si chiama Tango Tzigane Jalousie” disse: “Non l’hai mai sentita, la faremo solo per te …”.
Lasciò la frase sospesa puntandomi col dito, penso volesse sapere il mio nome ma non potevo permettere che si sapesse che ero stato lì e se per caso un giorno avesse creduto di vedermi tra la folla e mi avesse chiamato, avrebbero tutti detto che ero diventato amico dei gitani e questo mia madre non me l’avrebbe mai perdonato. Però mi piaceva l’idea di fuggire con loro, i miei amici gitani, ma gli alberi non parlano, io non parlai allora.
Citronceka era un gioco di fuoco e luci e io avrei vissuto una vita solo per farla star bene. Quello che dovrebbe fare ogni uomo sulla terra: rimanere immortale nella testa di una donna.
E’ per questo che le donne vivono più degli uomini: per poterli ricordare.
Il castigliano cominciò a suonare, la farfalla si chinò per afferrare un’invisibile nota caduta dal violino che s’era agitato disperato, l’afferrò prima che toccasse terra, rimase immobile e quando il tema iniziò la portò con sé, la nota, nella girandola che le fece volare in alto la gonna. Nonostante potessi finalmente vederle tutto, continuai a guardarla in viso. Dovevo avere un’espressione felice, avrei voluto vedermi, forse oggi mi ricorderei di me.
Ero piccolo sì, ma sapevo che lei era la donna perfetta per accudirmi. Non potevo toccarla, non potevo pensarla se non in quel buio in cui i sogni prosperano, non potevo comandarla, non potevo pretenderla, tutto ciò che era fatto, era fatto per amore, quello tipico dei divini albori della creazione, quello che non conosce carne, materia, ma è fatto soltanto d’impulsi. Citronceka era l’amore di un sognatore per le nuvole e se avesse vissuto un giorno in più di quanto ero destinato a vivere io, sarei stato comunque vivo anch’io.
Quando il violino si ammutolì di colpo, lei si volse verso me, allungò la mano e m’invitò a toccargliela per prendere l’ultima nota rimasta e ben difesa dai suoi pugni forti. L’accarezzai, quella mano, lo feci per qualche secondo ad occhi chiusi fin quando il mio corpo non fu frastornato da un piacevole fremito e io senza accorgermene mi bagnai le mutande ed emisi un leggero “uh”.
Mi accorsi d’essere diventato un uomo e in quel momento tutto quello mi spaventò, così corsi via in fretta con la mano stretta alla nota che la farfalla m’aveva donato, la nota della passione, quella che dà inizio a tutta la musica del mondo.
Consuelo, la donna di Maurice, diceva: “Si porteranno via in vostri mariti”.
Lei era catalana, come la maggior parte dei gitani che s’erano stabiliti dalle nostre parti e che giravano il mondo rubando un po’ della cultura dei popoli che li avevano ospitati per poi regalarla agli altri con le più disparate arti.
“Io le conosco bene, quelle femmine lì”.
Uscii fuori dalla porta proprio mentre mia madre e le sue amiche accolsero in casa gli stranieri dai modi gentili, così in contrasto con quel loro accento ammonitore.
“Siete solo gelosi di loro, della loro libertà, della loro bellezza” gridai, “non si può condannare i gitani all’Inferno, si commette un sacrilegio!”
Il signore in divisa sorrise e rimase immobile nonostante i pugni che gli sferrai all’addome.
“Ci porteranno via tutti” gridai le parole della cartomante, “chi condanna il cielo al rogo eterno, getta su di sé sventure tali che neanche la magia può combattere!”
Poi mi spinsero in terra. Sentii il pavimento sbattermi contro.
I gitani sapevano che prima o poi i crucchi li avrebbero presi e li avrebbero portati via, non hai un posto in cui nasconderti se ogni posto è la tua casa, ma avevano continuato a vivere come sempre avevano vissuto, aspettando l’Inverno, senza paura, come fanno gli alberi.
Il crucco che mi tirò per i capelli mi trascinò per qualche metro, non si accorse neanche che mia madre gli stava implorando di smetterla. Lui le mollò una guantata che la stese e tutte le altre donne si zittirono. Non so cosa volesse farmi, dove volesse portarmi, ma qualsiasi posto sarebbe stato meglio che a Pollestres. Mi mise su un’auto e un suo amico che parlava la mia lingua si sporse dal finestrino e disse: “Ci serfiranno al fronte ragazzi sfegli come foi francesi, pieni di fita e passione”.
Amavano la Francia, finita la guerra avrebbero preso le nostre terre e avrebbero riempito le strade dei loro ragazzini biondi e sbiancati.
Ero legato mani e piedi, ma non avrei mosso un dito anche se mi avesse lasciato libero di agire. La mia forza era nel mio silenzio. Poi l’auto si fermò e capii dal tintinnio del piscio s’una roccia che il crucco aveva bisogno di svuotare la sacca.
Mi ritrovai pieno delle sue cervella prima di capire cosa stesse succedendo.
Marcel Debar mi tirò fuori dall’auto, mi slegò e mi ordinò di correre a casa.
“Hai rischiato di morire per una donna. Questo ti fa onore ma in guerra con l’onore si diventa grandi senza crescere di un centimetro. E tu devi almeno arrivarmi fin qui, prima di fare certe stronzate”.
Lui non era alto ma io lo ero meno.
“Come ti chiami ragazzo?” chiese.
“Olivier” risposi.
“Bene Olivier, mi devi un grosso favore, non scordartelo mai”.
E il tempo del favore arrivò con una telefonata di Jacky, qualche anno dopo.
Adesso.
*****
Alcuni sostengono che noi nettoyans dovremmo scordarci di quello che è stato, che non si può giudicare il comportamento dei francesi durante la guerra, che in una situazione come quella ogni ragionevolezza sfugge all’umana coscienza. Altri ci considerano come quei nuovi eroi dei fumetti, eterei come leggende, giustizieri che agiscono nell’ombra, con doppie identità, senza nulla da perdere. Non tutti credono nella nostra esistenza, ma si guardano attorno sperando di scorgerci, angeli che agiscono in terra per conto di un’intelligenza superiore che viene dall’alto: per loro è Dio, per noi è la Repubblica Francese. Lo stato ci evita come fossimo pestilenti, ma noi non lo facciamo per amor di patria, tutti siamo spinti da un desiderio di vendetta, molti di noi hanno cominciato per fame.
La grande guerra era finita da un pezzo, ma a casa mia non leggevamo i giornali e facevamo poca vita sociale, così noi avevamo continuato ad avere fame come fossimo in piena battaglia. Arrivò questo tizio, un tipo educato, uno bravo a dire quel che non pensava e quel che gli altri volevano sentirsi dire. Lui era uno degli uomini più educati che mi avessero mai stretto la mano.
“Hai una pistola?”, mi chiese
“Tutti hanno una pistola”, risposi.
“Bene, se hai una pistola, sappi che io sono in cerca di qualcuno”.
“Ok” dissi, “io ho sempre desiderato essere qualcuno”.
Non mi diede alcun distintivo, né firmammo dei contratti, bastava la sua parola. Così cominciai a girare l’Europa in cerca dei miliziani rimasti, molto spesso persone per bene, padri e madri di famiglia che pensavano che agire per sopravvivere, che lo si chiamasse tradimento o paura, era una cosa lecita sotto le armi. Nostro era il compito di chiarir loro le idee. Quando cominciavano a percepire la nostra presenza non cercavano neanche di difendersi, si lasciavano morire. In fondo sapevano di essersi sporchi. Erano quasi sollevati di poter pagare finalmente per i loro crimini.
Adeline fu il mio primo contatto a Parigi, m’insegnò ad agire congelando i miei sentimenti, disse che c’erano migliaia di anime senza colpa che avevano pagato ingiustamente. Ma anche lei aveva i suoi turbamenti, la notte la sentivo digrignare i denti e le sue labbra erano martoriate dai continui morsi che si dava quando io non ero con lei nella sua modesta casa di Rue Ordener. Le anime di cui parlava erano persone a lei molto vicine, per questo decisi di darle l’illusione che il nostro fosse amore.
Mi disse “divertiti se puoi” e quel giorno con Hubert Fournier, mi mostrò lei come farlo senza rimorsi.
Mise un rosso rattoppo sul suo corpo e lo chiamò abito per abbindolare chi preferiva la fantasia dei sarti a quella di madre natura. Si sedette senza riguardo s’un beneducato sofà Walpole che con lei sopra rimase a fatica rigoroso e serio, come un segretario di stato con una squillo sulle ginocchia. Si morse le falangi e sorrise soddisfatta di quella mia fragilità che normalmente si nascondeva negli anfratti che una vita di rimpianti e violenza avevano scavato sul mio volto come vento salato su una scogliera. Di fronte a lei tutta l’austerità di un viso criminale si accasciava sfinita sulle mie labbra tremanti, intimorita dalla naturalezza con la quale rendeva peccaminosa la bellezza. Ero troppo giovane per comprendere che essere belli è come nascere ricchi ma con un’enorme quantità di debiti.
“Allora, Papillon?” mi chiese.
Tutti i nomi in codice cambiavano a ogni contratto, ma io non abbandonai mai il mio. Ero conosciuto come Olivier la farfalla, fu il primo nome che usai e quello che uso ancora.
Avevamo bevuto Cheval Blancs per tutta la notte e dopo avermi ridato indietro un po’ del suo sapore che distratto avevo perso nel fumo del raffinato tabacco di una Dunhill, mi disse di voler vivere per sempre in quel modo.
“Vuota e intrappolata nella rabbia di un passato che non puoi cambiare?”
“No” mi rispose, “piena e libera nel piacere di poter conservare qualcosa del presente”
Voleva scordarsi della guerra e vivere il momento, infestata dei parassiti che il solo denaro contante può attaccarti.
Di fronte a noi Fournier ci implorava di non ammazzarlo, sembrava un bambino, aveva perso tutto quel fascino dannato della spia nazista. I crucchi lo avevano fatto sentire uomo, noi invece lo stavamo spogliando e ce lo giocavamo a testa o croce per la nullità che era.
Adeline mi si avvinghiò come un boa e mi baciò come le fiamme dell’Inferno baciano un dannato appena sbarcato sulle sponde dell’Ade.
“Perché non dovrei?” chiesi a Faurnier e lui non seppe darmi risposta.
“Non davanti a mia figlia, almeno”, fu l’unica cosa che disse.
Da dietro una verde rigogliosa Kentia spuntò una bimba di dieci anni. Non tremava, era forte come me alla sua età, silenziosa e immobile come un albero.
Mi guardò per non scordarsi il mio volto sicura che a lei avrei risparmiato la vita solo perché indossavo una donna come un collo di pelliccia di volpe. Era coraggiosa, sì, come me alla sua età. La abbracciò, il papà, e le disse di correre nella stanza sul retro e di tapparsi le orecchie. Le voleva salvare l’infanzia e la vita, come Maurice Debar aveva fatto con me. Lo capivo bene.
Avessi avuto un padre così adesso vivrei a Cannes, pescherei sogliole e seppie e avrei sposato la mia compagna di scuola Doriane. Il vecchio Boniface invece si ubriacava perché non aveva il fegato di accettare la sua vita. Morì come muoiono gli uomini come lui. Il vuoto creato da tutto quel sangue mi è rimasto accanto, non dentro, ma accanto, divorando ogni gioia che mi si avvicinava: le feste di compleanno, il primo bacio, la prima sbronza con gli amici.
“Io penso al padre, tu pensa a lei” mi disse Adeline che a cavalcioni sull’uomo premette il grilletto e si sporcò del più grande dei crimini che una donna può commettere: la fretta.
Misi la mia Luger in mano alla piccola e infilai la canna nella mia bocca. Le chiesi di sparare se questo poteva renderle più dolce l’adolescenza.
La piccola mi risparmiò la vita donandomi la redenzione e liberandosi dal gusto della violenza che se assaporata da piccoli ti rimane per sempre in bocca. Lo avessi fatto io quando potevo, sarei ancora in ginocchio s’una panca a mugugnare preghiere.
Um cha, cha, regina, cha. Amen, cielo, padre cha.
Mi sarei accontentato di un’altra corsa fino al centro di Pollestres prima di entrare per sempre in questa mia nuova vita portandomi addosso ogni giorno, fino alla casa decisa per me dal governo francese, il vuoto di un altro fallimento, l’odore del sesso e il violento sguardo di una vogliosa nettoyans per la Rue De la Gaité di Montparnasse.
*****
Aspetto che il mio contatto per non so dove, mi dica di ammazzare non so chi, non so quando, con una mano in tasca e una che ciondola nel vuoto. Sto di fronte a un camion che trasporta vino buono in bottiglie di vetro ancora da etichettare.
Se uno di quei manovali fosse volenteroso abbastanza, potrei superare l’attesa con un bel sole in faccia e la mente sgombra.
Un uomo in bretelle e camicia a quadri mi guarda girare in tondo nei pressi del veicolo, forse spinto dalla bontà divina mi chiede: “Hey, ragazzo, lo reggi l’alcol?”
L’amore di Bacco albeggia sempre sui nasi gonfi della gente sola, triste e annoiata e io lo ringrazio a braccia aperte.
“Sì, certo che sì, signore”, rispondo felice.
“Ecco”, mi dice quello mettendomi tra le mani una cassa da dieci: “Reggi questa e portala dentro visto che non c’hai un cazzo da fare, poi siediti a un tavolo e aspettami lì”.
L’uomo è Maurice Debar, non è più una spia della repubblica, non è niente e nessuno, ma per me è tutto o quasi. Dice di aver comprato il bistrot di Rue De Pigalle di Fredo e che adesso ha intenzione di rimanere fuori dai giochi fino a quando non ricominceranno a sparare sulle folle.
“E prima o poi lo rifaranno, ragazzo” dice, “lo rifaranno quei maledetti crucchi torneranno e ci costringeranno a dover difendere questo ben di Dio un’altra volta”.
Per tutto il tempo il suo bicchiere pieno dev’essersi sentito come un messicano all’ufficio passaporti.
“Mio nonno è morto per quella roba”, gli dice Jacky, la sua donna che ha vent’anni meno di lui: “E’ per questo che ti chiedo di smettere di bere”.
“Il mio è morto mentre scopava” le risponde Maurice: “Ma se non sbaglio non ti ho mai chiesto di smettere di scopare”.
L’ha salvata da morte certa un giorno durante la guerra, da Hans, un crucco che l’aveva violentata e poi lasciata ai suoi amici. Lei per quello gli è riconoscente, si vede da come scatta via al bancone quando lui glielo ordina.
Maurice giocherella con un pezzo di carta e ride senza dirmi il motivo, non è una risata che vuole prendere in giro, è più qualcosa che viene da una bella sensazione.
“Papillon” dice, “non hai mai dimenticato la tua farfalla gitana, non è così?”
Non sono a questo tavolo per fare conversazione, ma per togliermi un debito di vita.
“Non ti ho chiamato per farmi un favore” dice Maurice, “almeno non solo, voglio che te ne faccia uno invece”.
“Potrei tornare dalla mia donna e fare l’amore con lei allora”.
“A giudicare dal tuo soprannome, non c’è altra donna che vorresti di fronte, se non quella che troverai e ammazzerai per conto mio”.
D’un tratto la sua spavalderia perde colpi, si accascia come uno di quei sudici barboni al bar che hanno appena fatto fuori le loro offerte riempiendosi di rosso di seconda scelta.
“Avrei dovuto ucciderla io molto tempo fa” singhiozza un sorriso che gli fa sussultare il corpo per intero, “ma ero ancora troppo innamorato per farlo, nonostante stesse coi crucchi. Lei diceva di no, ma io sapevo che era quella la sua attività principale”.
C’è gente che pensa che noi nettoyans potremmo scordare se solo volessimo, ma non possiamo scordare se anche gli altri non scordano. Noi non agiamo per conto nostro ma su ordine dei francesi, che sia una vecchia spia in cerca dell’onore perduto per mano di qualche puttana catalana o del popolo tutto.
Mi dà il nome e dice: “E’ lei, ragazzo, che ha tradito me e te, la tua farfalla danzante è morta per la sua disonestà”.
Ho vissuto anni solo per avere il suo nome.
*****
C’è una notte eccessivamente luminosa a Parigi.
Sono dietro la tenda, mi ha visto, lo so.
“Sono qui per ucciderti, Consuelo”, le dico: “Puoi scalciare e piangere come una bambina o puoi morire come una vera donna”.
“Come muoiono le vere donne?” mi chiede lei, bella e stupita come una sedicenne dopo la sua prima volta.
“Non so, credo con indosso un vestito costoso e cadendo sul letto in slow motion accompagnate da una bella melodia”.
Sorride e mi chiede se posso almeno offrirle da fumare l’ultima sigaretta.
Apro il pacchetto e “no, non è l’ultima, ne ho ancora una decina, ma mi hai fatto ricordare che devo comprarle”, le dico.
Prende quella di centro senza farsela scappare neanche una volta nonostante le unghie da gatta.
L’accende.
“Scommetto che non puoi dirmi il tuo nome, fate così voi assassini, non è vero?”
“Sì” le rispondo, “ma è un’usanza stupida visto che non potreste rivelarlo a nessuno in questa terra. Mi chiamo Olvier”.
“Secondo te esiste un Dio, Olivier?”, mi chiede.
“Non che io sappia”, rispondo con l’unica risposta possibile e che abbia una logica.
Tossisce e mi chiede che musica suonerò dopo averla ammazzata, visto che in mano ho il mio violino e una vecchia Mauser datami da Maurice.
“Tango Tzigane Jalousie”, le mostro lo strumento e lo poggio sul sofà: “S’intona con il vestito rosso che porti”.
“Puoi dirmi almeno perché lo fai?” domanda tossendo il fumo delle mie Dunhill perché la paura le chiude i polmoni.
Non gliela dico tutta, le rivelo soltanto che sono lì per chiudere i conti della guerra.
“Cos’hai contro la guerra Olivier? Tutto è come la guerra.”
Non vuole morire, si vede da come il suo accento catalano si è fatto vivo e passionale.
“Mentire in silenzio è come la guerra” urla, ma poi la sua voce si fa sottile perché le ho detto che al primo schiamazzo la farò fuori.
“E’ come la guerra che un figlio finisca per strada. Che un padre rinneghi il suo seme, una madre il suo sangue, ricevere soltanto e mai dare: è tutto come la guerra. E’ come la guerra dimenticare i tuoi cari, abbandonare persone come cani, cani come oggetti.
Quando qualcuno comprende di essere qualcosa ma non abbastanza è come la guerra. I ricchi cristiani che accumulano ricchezze in nome di Dio sono come la guerra e come la guerra è schernire un diverso, ingiuriare un debole, ingannare un amico, violentare un’amante …
Ci venite a chiedere delle nostre armi, cercate di comprendere le nostre logiche, Olivier, ma hanno mille ragioni d’esistere e quindi nessuna in particolare.
Noi non esigiamo risposte da chi, pur amando, ha deciso di tradire: eppure anche quello è come la guerra.”
Scuote la testa, il destino vuole che il tango della gelosia sia il suo tango preferito, almeno lo sono i primi dieci secondi: come me odia quell’inutile pezzo centrale in cui la passione fa spazio alle pessime influenze che l’operetta ha avuto sui suonatori europei.
“Vorrei poterla ascoltare”, mi dice.
Nonostante come ogni artista io sia un privilegiato, come i peggiori assassini porto con me un’eterna condanna, quella di non poter ricevere mai un applauso dal mio pubblico.
Le sparo un colpo al cuore e “l’ascolterai” le dico.
Il cervello rimane in vita per qualche istante dopo la morte e quell’istante mi basta per suonare i miei e i suoi dieci secondi preferiti, gli unici che valgano la pena di essere ascoltati, gli unici che Consuelo può sentire.
E’ dopotutto un buon finale per una donna del suo calibro.
Alessandro Cascio